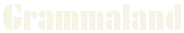La verità è nel fondo di un pozzo
Leggere o rileggere Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia per cercare di capire qualcosa di fondamentale sull’Italia e sulla letteratura.
L’autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell’alba, sfilacce di nebbia ai campanili della Matrice: solo il rombo dell’autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde panelle, implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l’autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L’ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza, colse l’uomo vestito di scuro che veniva correndo; il bigliettaio disse all’autista «un momento» e aprì lo sportello mentre l’autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati: l’uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile; gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò.
Cercate un giallo che non si perda in chiacchiere e vada subito al sodo? Nel Giorno della civetta, a Leonardo Sciascia bastano poche righe per mettere in scena il primo delitto, quello attorno al quale ruota l’intera vicenda. Le quattro pagine seguenti, invece, servono a dimostrare che il romanzo è sì un giallo, ma anche molto di più.
Il venditore di panelle (sono focacce di farina di ceci), a tre metri dal morto, «muovendosi come un granchio cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa»; allo stesso modo, i passeggeri dell’autobus, «voltandosi indietro come a cercare la distanza giusta per ammirare i campanili», spariscono nei vicoli attorno alla piazza; quando arrivano i carabinieri, autista e bigliettaio dichiarano di non aver visto nulla e non ricordano nemmeno se c’era qualcuno sull’autobus; il maresciallo esulta quando il carabiniere Sposito si rende conto che dalla scena del delitto manca il panellaro; lo manda a prendere alle scuole e lo interroga:
«… voglio sapere una cosa sola, me la dici e ti lascio subito andare a vendere le panelle ai ragazzi: chi ha sparato?»
«Perché» domandò il panellaro, meravigliato e curioso «hanno sparato?»
Insomma, bastano quattro pagine per capire che Il giorno della civetta è il libro fondamentale sulla mafia, sull’omertà, sul destino della Sicilia, e lo è anche per una ragione che oggi forse ci pare stupefacente: prima della sua uscita, nel 1961, non esistevano gialli incentrati sui delitti di mafia, anzi di mafia proprio non si parlava nei libri. Come ripetono più volte alcuni personaggi del romanzo, nell’Italia attorno al 1960 «la mafia non esiste» (ed era questa la risposta usuale dei rappresentanti del governo alle interrogazioni parlamentari).
Per noi lettori di oggi, però, la primogenitura potrebbe non avere molta importanza. Il fatto è che Il giorno della civetta è un libro magnifico in sé, ben al di là del suo innegabile valore storico, politico e civile.
È il libro più celebre (in tutto il mondo) di un autore che ha due caratteristiche non troppo usuali nella letteratura italiana: intanto, non è interessato a parlare di sé ma vuole raccontare i «fatti degli altri»; in più, è abituato a dire solo lo stretto indispensabile, e a tagliare tutto il superfluo: nei suoi libri non c’è mai una parola di troppo, e tutte sono indispensabili (questo significa che non ci si deve distrarre: un romanzo di Sciascia si può leggere in un pomeriggio, ma ogni tanto conviene tornare indietro, per accertarsi di non essersi lasciati sfuggire qualcosa).
In questo caso specifico, come spiega l’autore nella nota finale, la laconicità non è del tutto spontanea: è anche un espediente necessario per evitare denunce per «oltraggio e vilipendio».
Quando mi sono accorto che la mia immaginazione non aveva tenuto nel dovuto conto i limiti che le leggi dello Stato e, più che le leggi, la suscettibilità di coloro che le fanno rispettare, impongono, mi sono dato a cavare, a cavare.
Questa scelta forzata, tuttavia, si rivela, dal punto di vista stilistico e narrativo, una mossa vincente. Il romanzo racconta, con esemplare chiarezza, da un lato la storia di tre delitti di mafia e delle indagini condotte dal capitano dei carabinieri Bellodi, originario di Parma, ex partigiano, destinato per tradizione di famiglia alla professione di avvocato ma che ha scelto, con il «mestiere delle armi», di servire e far rispettare «questa legge che assicurava libertà e giustizia, la legge della Repubblica»; e dall’altro mostra, con una serie di «dietro le quinte», le azioni di personaggi senza nome (ma capiamo che si tratta di capi mafiosi, alti funzionari governativi in Sicilia, deputati, esponenti di partito, membri del governo nazionale) che commentano l’inchiesta e danno istruzioni per evitare che la verità venga a galla, anzi per creare una verità alternativa.

Non preoccupatevi: non ho intenzione di rivelare altro della trama. Citerò solo la scena più celebre del romanzo, uno degli interrogatori più memorabili nella storia del giallo letterario non solo italiano: il confronto senza esclusione di colpi tra il capitano Bellodi e il più potente capomafia della zona, l’anziano don Mariano Arena, «amato e rispettato da un paese intero, prediletto da me» (come afferma uno di quei personaggi senza nome) «e carissimo all’onorevole Livigni e al ministro Mancuso».
Bellodi sa che non riuscirà mai a «incastrare nel penale» un boss come don Mariano: «non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti e dei disonesti lo proteggerà sempre». Prova così a colpirlo sul versante dell’evasione fiscale (come si era fatto negli Stati Uniti con Al Capone), e mostra, grazie a una serie di indagini bancarie che ha intenzione di trasmettere al fisco, che don Mariano Arena dispone di molti più soldi rispetto alle rendite che dichiara di possedere. Poi tocca un altro tasto delicato: la figlia, che studia in un costosissimo collegio a Losanna, in Svizzera.
«[…] lei sta facendo di tutto perché sua figlia non sia come lei, perché sia diversa… E quando non riconoscerà più sua figlia, tanto sarà diversa, lei avrà in qualche modo pagato lo scotto di una ricchezza costruita con la violenza e la frode…»
Nel mezzo del duello – prima che Bellodi legga ad Arena le confessioni dei mafiosi di basso grado e ricostruisca davanti a lui gli episodi che dimostrano la sua influenza nel sistema degli appalti pubblici – don Mariano Arena si produce in una classificazione dell’umanità che è una delle ragioni per cui è tanto celebre Il giorno della civetta. Per lui, che ha «una certa pratica del mondo», l’umanità si divide in cinque categorie: gli uomini («pochissimi»), i mezz’uomini, gli ominicchi («che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi»), i pigliainculo («che vanno diventando un esercito») e i quaquaraquà («che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre»).
«Lei,» [dice infine al capitano Bellodi] «anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo…»
Perché un capomafia tributa a un nemico un riconoscimento così esplicito?
«Perché» disse don Mariano «da questo posto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia di un uomo: e lei invece ha rispetto… Da persone che stanno dove sta lei, dove sta il brigadiere, molti anni addietro io ho avuto offesa peggiore della morte: un ufficiale come lei mi ha schiaffeggiato; e giù, nelle camere di sicurezza, un maresciallo mi appoggiava la brace del suo sigaro alla pianta dei piedi, e rideva… E io dico: si può più dormire quando si è stati offesi così?».
Anche Bellodi, d’impulso, riconosce che don Mariano è un uomo (a differenza, per esempio, dei suoi protettori politici, l’onorevole Livigni e il ministro Mancuso), e proprio questa scena è costata a Sciascia l’accusa di simpatia o addirittura connivenza con la mafia. È un’accusa che non ha senso (in nessun punto del libro il giudizio sulla mafia è ambiguo). In realtà, la scena ci fa capire che Il giorno della civetta è sì un libro sulla mafia e sulla Sicilia, ma prima ancora è un libro sul potere. Ci fa scorrere davanti agli occhi le varie e inconciliabili forme che assume il potere.
Bellodi considera il potere, l’autorità di cui dispone in quanto ufficiale dei carabinieri, «come il chirurgo considera il bisturi: uno strumento da usare con precauzione, con precisione, con sicurezza»; per lui la legge era «scaturita dall’idea di giustizia e alla giustizia congiunto ogni atto che dalla legge muovesse». Per il confidente interrogato dal capitano, invece, il potere del carabiniere è «la felicità della forza e del sopruso, tanto più intensa quanto più grande la misura di sofferenza che ad altri uomini si può imporre». È una visione simile a quella del vecchio che ha chiamato Barruggieddu il suo cane «cattivo quanto un diavolo», perché un tempo i Barruggieddi «comandavano i paesi e mandavano gente alla forca, per piacere malvagio» (e solo allora Bellodi capisce che quello è il termine siciliano per Bargello, «il capo degli sbirri»). C’è il potere secondo i notabili del partito di governo, vale a dire il mantenimento dello status quo, in base al quale gli amici e gli amici degli amici potranno continuare a spartirsi soldi e influenze in Sicilia e faranno di tutto perché da Roma non si interrompa l’afflusso di risorse. C’è il potere dei capimafia: il potere assoluto di giudicare «morto nel cuore degli amici» (vale a dire di condannare a morte senza nemmeno bisogno di pronunciare una sentenza) un uomo che ha commesso uno sgarro. E infine c’è la tentazione provata da Bellodi che, come i suoi sottoposti, sperimenta «l’angustia in cui la legge lo costringeva a muoversi» e sogna «un eccezionale potere, una eccezionale libertà di azione»:
Una eccezionale sospensione delle garanzie costituzionali, in Sicilia e per qualche mese: e il male sarebbe stato estirpato per sempre. Ma gli vennero alla memoria le repressioni di Mori, il fascismo; e ritrovò la misura delle proprie idee, dei propri sentimenti.
Bellodi sogna il potere che, durante il fascismo, consentì al prefetto Mori di tenere, almeno in parte, la mafia sotto scacco (è probabile che le umiliazioni subite da don Mariano risalissero a quell’epoca). Poi però ritrova «la misura delle proprie idee», si rende conto che il fine non potrà mai giustificare mezzi indegni, e soprattutto che quel potere senza bilanciamenti si trasformerebbe in arbitrio, o perfino in uno strumento per regolare i conti tra cordate rivali all’interno del partito di governo.
* * *
Se Il giorno della civetta è un libro sul potere, è anche, ancora più a fondo, un libro sulla verità: sul rapporto tra letteratura e verità, cioè sulla questione capitale delle verità che possiamo cercare e trovare nei libri.
La prima verità è quella narrativa, letteraria: qualunque autentica opera di letteratura illumina o crea una realtà che resta scolpita nella mente del lettore. Fin dal primo capoverso, è la verità di sensazioni sonore che imprimono il carattere a tutta una scena («l’autobus si mosse con un rumore di sfasciume») o di immagini precise, nitide, inconfondibili (l’uomo colpito che resta «per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile»). Ma si potrebbe dire che ogni singola parola del libro ha lo scopo di restituire la verità: basti pensare all’altra scena, curiosamente simile, del cane (il già citato Barruggieddu) che di notte, in una pietraia desolata, «improvvisamente scattò nel raggio che la corda che lo legava ad un albero gli consentiva: restò come sospeso al collare che lo soffocava, rabbiosamente abbaiando».
Poi c’è la verità della trama gialla: grazie alle informazioni raccolte, alle indagini svolte, all’astuzia e alla logica ferrea di Bellodi e dei carabinieri siciliani suoi sottoposti, i delitti trovano una spiegazione appagante, che soddisfa le legittime richieste dei lettori, anche quelli appassionati di polizieschi.
A questa verità, però, se ne affianca un’altra: è la verità alternativa, fondata sull’assioma che «la mafia non esiste» (e che per questo tira fuori la pista, fino a quel momento giustamente ignorata, del delitto «passionale»). Questa spiegazione non può essere messa sullo stesso piano di quella fornita dalle indagini, anzi noi sappiamo che si tratta di una menzogna; ma nella Sicilia del 1960, le forze che non vogliono colpire la mafia (perché proteggono la mafia e ne sono protette) non solo esistono, ma sono potenti, e un romanziere che intenda raccontare le cose come stanno ha il dovere di tenerne conto.
Nel libro di Sciascia c’è un ulteriore livello di «verità»: sono le frasi che da allora sono passate in proverbio, e hanno contribuito a definire alcune nozioni chiave relative alla Sicilia e alla mafia. Una è la classificazione di cui abbiamo già parlato, le cinque categorie da uomini a quaquaraquà (una parola che troverete sul dizionario, e la data di «prima attestazione» sarà proprio il 1961, cioè l’anno di uscita del romanzo). È «vera» perché, da allora, è impossibile ignorarla, ma conviene tener presente che, in mano a un mafioso come don Mariano Arena, la classificazione diventa un comodo alibi. Quando il capitano Bellodi gli chiede se è «cosa da uomo ammazzare o fare ammazzare un altro uomo», Arena dice subito che lui non ha mai fatto niente di simile, ma che comunque, ragionando in astratto, «a passatempo», sul fatto che sia giusto togliere la vita a un uomo, «io dico: prima bisogna vedere se è un uomo» (e infatti per lui il morto ammazzato di cui si parla «era un quaquaraquà»).
Anche sulla verità di un’altra celebre espressione bisogna intendersi. È l’idea della «linea della palma» esposta, nelle ultime pagine del libro, da un amico parmigiano del capitano Bellodi, il medico Brescianelli:
«Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia… A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno… La linea della palma… Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato… E sale come l’ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l’Italia, ed è già oltre Roma…»
Qui l’immagine non va presa alla lettera (le palme si sono acclimatate da decenni in molte località settentrionali, dalla Liguria ai laghi prealpini, e una risalita di 500 metri l’anno significherebbe 30 chilometri in 60 anni: niente di troppo preoccupante…); ma come metafora dell’espansione della criminalità mafiosa quella della linea della palma ha avuto un immenso successo, è diventata il titolo di svariati libri e di infiniti articoli.
Un’altra frase passata in proverbio riguarda proprio l’idea stessa di verità:
«La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità.»
È una frase del capomafia don Mariano Arena, e ci pensa subito il capitano Bellodi a toglierla dalla dimensione della vaga astrattezza sapienziale.
«Lei ha aiutato molti uomini» disse il capitano «a trovare la verità in fondo al pozzo.»
L’ultima verità del libro è tragica e paradossale. È un aneddoto che racconta Bellodi ai suoi amici parmigiani, per spiegare la realtà della Sicilia. È la storia di un medico del carcere palermitano dell’Ucciardone, deciso a stroncare lo scandalo del trattamento di favore di cui godevano i mafiosi: invece di starsene in cella, occupavano le stanze dell’infermeria, nonostante fossero sanissimi e, così facendo, togliessero il letto a detenuti davvero malati, perfino tubercolotici. (Questa prassi era in quegli anni comunissima: in alcune carceri i mafiosi spadroneggiavano.) Una notte, il medico viene convocato in carcere col pretesto di visitare un detenuto, si ritrova in mezzo ai carcerati senza che ci siano secondini o funzionari nei dintorni, e viene picchiato a sangue da alcuni capimafia. Il medico chiede giustizia, alcuni di coloro che l’hanno picchiato vengono trasferiti, ma il ministero lo solleva dall’incarico (crea troppi problemi) e perfino i dirigenti del partito di sinistra a cui appartiene gli consigliano di starsene tranquillo.
Non riuscendo ad ottenere soddisfazione dell’offesa ricevuta, si rivolse allora a un capomafia: che gli desse la soddisfazione, almeno, di far picchiare, nel carcere dove era stato trasferito, uno di coloro che lo avevano picchiato. Ebbe poi assicurazione che il colpevole era stato picchiato a dovere.
Le ragazze trovarono delizioso l’episodio. Brescianelli lo trovò terribile.
Anch’io lo trovo terribile: un «buono» senza macchia e senza paura si rivolge ai mafiosi per ottenere non giustizia ma «soddisfazione dell’offesa». Il libro si conclude con una verità fin troppo ambigua, e amara, Ma non è colpa di Sciascia se le cose stavano così. Le ultimissime parole del romanzo, però, toccano al capitano Bellodi, in licenza per malattia, e non sono parole di sconfitta.
Ma prima di arrivare a casa sapeva, lucidamente, di amare la Sicilia, e che ci sarebbe tornato.
«Mi ci romperò la testa» disse a voce alta.
Il giorno della civetta (Einaudi 1961, oggi disponibile, come gli altri libri dell’autore, presso Adelphi) è il primo romanzo di Leonardo Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921 – Palermo, 20 novembre 1989), scrittore, saggista, poeta, giornalista, politico. Tra gli altri ricordiamo Il Consiglio d’Egitto (1963), A ciascuno il suo (1966), Todo modo (1974), 1912 + 1 (1986) e il folgorante Una storia semplice (1989), uscito in libreria il giorno della morte di Sciascia.