
Ruba il cappello al monachicchio
Leggere Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi e rendersi conto di aver coltivato per decenni un pregiudizio sbagliato.
Nel 2012 sono stato per la prima volta a Matera. L’avevo vista tante volte in fotografia, in servizi televisivi, perfino al cinema, ma nessuna immagine potrà mai preparare all’emozione che qualunque visitatore prova di fronte a una città indescrivibile (a Matera, per esempio, non si sale, ma si scende, come nel cratere di un vulcano).

Ora, Matera è consacrata al culto di Carlo Levi: nel museo della città un’intera sezione è dedicata ai suoi quadri, e la guida che mi ha portato a visitare un «sasso» – una casa-grotta scavata nella roccia e allestita esattamente come era negli anni Trenta, con il grande letto per tutta la famiglia, le culle degli ultimi nati sospese a mezz’aria e lo spazio per gli animali – citava a memoria intere frasi da Cristo si è fermato a Eboli per darmi un’idea delle spaventose condizioni di vita in quei tuguri che oggi, ristrutturati, finiscono sulle riviste di architettura.
Neppure l’emozione di Matera, però, mi ha spinto a conoscere più a fondo Levi: non sono entrato nel museo, e non mi è venuta la voglia di leggere Cristo si è fermato a Eboli. A bloccarmi era un doppio pregiudizio, che il libro di Levi fosse «neorealista» e che fosse l’esempio prototipico di «narrativa per la scuola media»: dunque una storia triste di gente povera che si esprime in dialetto e/o sbaglia apposta i congiuntivi, definitivamente assassinata da apparati didattici punitivi.
Poi, quando finalmente mi sono deciso ad aprire Cristo si è fermato a Eboli – convinto da un amico a cui avevo raccontato del mio entusiasmo per Un anno sull’Altipiano, e che aveva risposto comunicandomi il suo per il libro di Levi – mi sono trovato di fronte pagine come questa:
I monachicchi sono gli spiriti dei bambini morti senza battesimo: ce ne sono moltissimi qui, dove i contadini tardano spesso molti anni a battezzare i propri figli. […] I monachicchi sono esseri piccolissimi, allegri, aerei: corrono veloci qua e là, e il loro maggior piacere è di fare ai cristiani ogni sorta di dispetti. […] Portano in capo un cappuccio rosso, più grande di loro: e guai se lo perdono: tutta la loro allegria sparisce ed essi non cessano di piangere e di desolarsi finché non l’abbiano ritrovato.
Con tranquilla oggettività, Carlo Levi racconta che, nelle campagne della Basilicata, alcuni operai impegnati nella manutenzione di una strada chiedono l’aiuto dell’ingegnere a capo dei lavori, «un uomo istruito», per scacciare un monachicchio che infesta la grotta dove vorrebbero riposarsi, al riparo dal sole.
L’ingegnere imbracciò il fucile, che aveva caricato a palla, e lasciò partire un colpo. La palla colpì il monachicchio, e rimbalzò indietro verso quello che l’aveva tirata, e gli sfiorò il capo con un fischio pauroso, mentre lo spiritello saltava sempre più in alto, in preda a una folle gioia. L’ingegnere non tirò il secondo colpo: ma si lasciò cadere il fucile di mano: e lui, il capomastro, gli operai e Carmelo, senza aspettar altro, fuggirono terrorizzati.
I monachicchi non sono le uniche creature fantastiche della Basilicata. La madre del giovane Carmelo, operaio e aspirante corridore ciclista, è una strega che conversa con le anime dei morti e incontra monachicchi e veri diavoli, al cimitero, pur essendo «una contadina magra, pulita, e di buon umore». Le streghe sono ovunque, e passano il tempo a preparare filtri d’amore o di maleficio. I fantasmi dei suonatori della banda di Grassano, precipitati in fondo a un burrone di ritorno da un concerto, a mezzanotte riprendono a suonare i loro strumenti. I sonnambuli sono in realtà licantropi, che la notte corrono con i lupi. Una donna ha due madri, una vacca e una donna, e i vecchi ricordano distintamente entrambe. La capra è l’animale diabolico per eccellenza: non un diavolo in senso cristiano, ma un antico demone, una potenza, «un povero Satiro fraterno e selvatico in cerca d’erba spinosa sull’orlo dei precipizi»…
Insomma, il libro che avevo evitato per decenni era tutt’altro che la grigia rassegna di sciagure che mi ero figurato. Quando, nel 1935, Carlo Levi, laureato in medicina, pittore, viene mandato al confino per la sua attività antifascista, si trova davanti, nei paesi lucani di Grassano e Aliano, un mondo infinitamente lontano dalla sua Torino. E quando, tra 1943 e 1944, scrive il suo romanzo-memoriale Cristo si è fermato a Eboli, decide di raccontare quel ricchissimo patrimonio di folclore, storie e leggende senza il filtro dell’intellettuale, dell’«uomo istruito», ma con lo sguardo del contadino. Quindi descrive in maniera oggettiva, come se stesse presentando fatti quotidiani, il comportamento e le avventure di esseri sovrannaturali: non «Carmelo sosteneva che…» o «secondo le leggende…», ma la narrazione all’indicativo di quella che per i contadini è la realtà sperimentata ogni giorno. È un espediente estremamente efficace, che ci immerge subito nello spirito di un mondo ormai perduto. Un mondo che tuttavia Levi analizza e interpreta, dall’interno, attraverso gli strumenti della storia e dell’antropologia, e di una scrittura insieme affilata e partecipe.
«Noi non siamo cristiani»: sono gli stessi contadini a dirlo, perché «Cristo si è fermato a Eboli», cioè vicino al mare, senza addentrarsi «nelle desolate terre di Lucania». Cristiani qui significa «uomini», e la frase proverbiale esprime un doloroso senso di inferiorità, la consapevolezza di non essere padroni del proprio destino, di dipendere dal volere dei signori e dai capricci della natura. Ma cristiani si riferisce anche alla religione, e in effetti queste sono terre pagane (pagano deriva da pagus, in latino «villaggio», perché nelle campagne il cristianesimo arrivò molto più tardi che nelle città). Non c’è posto per la religione perché «tutto è magia naturale», «tutto è, realmente e non simbolicamente, divino».
Lo dimostra proprio il culto della potentissima Madonna nera di Viggiano, la cui immagine, appesa in ogni casa sopra il letto, «assiste, con i grandi occhi senza sguardo nel viso nero, a tutti gli atti della vita». Così si manifesta durante la sua festa, in settembre, portata in processione:
La Madonna dal viso nero, tra il grano e gli animali, gli spari e le trombe, non era la pietosa Madre di Dio, ma una divinità sotterranea, nera delle ombre del grembo della terra, una Persefone contadina, una dea infernale delle messi.
È una potenza della terra che può fare tutto, distruggere e proteggere a suo imperscrutabile giudizio, e ai suoi devoti non resta altro che adorarla. È l’immagine della natura, e la vita dei contadini, fuori dal tempo e dalla storia, è un tutt’uno con la natura. Ma lo stato di natura in cui si trovano è infinitamente lontano dalla felicità: questa «terra oscura, senza peccato e senza redenzione», è abitata dal male, «un dolore terrestre» che «sta per sempre nelle cose».
Il colore dei contadini è il nero, il nero del volto della Madonna di Viggiano, il nero che ritorna come filo e tema conduttore del romanzo, «quello stesso dei loro occhi tristi e dei loro vestiti, e non è un colore, ma è l’oscurità della terra e della morte».
Miseria, malattia, morte: ecco lo stato di natura, almeno nelle campagne lucane degli anni Trenta. Per i contadini non c’è speranza. Moltissimi emigrano in America, e infatti nelle case, accanto all’immagine della Madonna nera c’è la stampa a colori non del re d’Italia, non di Mussolini, men che meno di Garibaldi, ma del presidente americano Roosevelt. (Se la Madonna è la feroce, spietata signora di questo mondo, Roosevelt è il «Dio benevolo e sorridente» dell’altro mondo, e spesso in mezzo a loro, Spirito Santo di questa trinità, c’è un biglietto da un dollaro.) Anche se fanno fortuna, gli emigranti perdono tutto durante la grande depressione, oppure sperperano i risparmi di una vita comprando in paese terre dure e sterili. Se un contadino trova un tesoro (le grotte ne pullulano) non riuscirà a metterci le mani, perché allo spuntare del giorno l’oro si trasforma in carbone. Se, dopo secoli di «mite pazienza», decidono di ribellarsi, il risultato è un «desiderio cieco di distruzione», una «volontà di annichilimento, sanguinosa e suicida»: «si levano per la morte, bruciano il municipio o la caserma dei carabinieri, uccidono i signori, e poi partono, rassegnati, per le prigioni».
Le pagine più terribili del libro (le più famose, e avranno anche un impatto significativo sulla storia della Basilicata) sono quelle che descrivono le disumane condizioni di vita dei ventimila abitanti dei Sassi di Matera. La voce narrante, qui, è della sorella di Carlo Levi, Luisa, che passa da Matera prima di andare a trovarlo. È una città che sembra sia stata colpita dalla peste, e sono in particolare i bambini a riempire di orrore Luisa, che pure è medico ed è abituata a vedere ogni giorno bambini poveri e malati. Ma qui sono coperti di croste e pidocchi, colpiti da un’infezione agli occhi trasmessa dalle mosche, il tracoma, scossi dalla febbre della malaria, e mendicano disperati un po’ di chinino.
Anche Carlo Levi, a Gagliano (così si chiama Aliano nel romanzo), fa tutto quanto è in suo potere per aiutare la popolazione: quindi cura i contadini, che lo preferiscono di gran lunga ai due medicastri del paese («medicaciucci»), si prodiga per migliorare le condizioni igieniche, scrive anche un memoriale con tutte le azioni necessarie per limitare la diffusione della malaria, e lo fa avere, attraverso il podestà, alla prefettura di Matera. In particolare, dedica una grande attenzione ai ragazzi, che sembrano incarnare l’essenza profonda della vita del luogo.
Tutti questi bambini avevano qualcosa di singolare; avevano qualcosa dell’animale e qualcosa dell’uomo adulto, come se, con la nascita, avessero raccolto già pronto un fardello di pazienza e di oscura consapevolezza del dolore.
Vanno a casa di Levi, giocano col suo cane Barone, gli portano il cavalletto, la tela, la cassetta dei colori quando esce a dipingere, e proprio la loro vitalità contrasta con la desolazione, il dolore, la morte che caratterizzano la vita dei contadini e di cui i bambini stessi sono pienamente consapevoli.
È un contrasto che Levi mette in risalto a Carnevale, quando si offre di creare delle vere maschere con cui possano travestirsi.
Non so perché, ma forse per il ricordo delle funebri maschere contadine, o spinto, senza volerlo, dal genio del luogo, le feci tutte uguali, dipinte di bianco e di nero, e tutte erano teste di morto, con le cavità nere delle occhiaie e del naso, e i denti senza labbra. I bambini non si impressionarono, anzi ne furono felici, e si affrettarono a infilarle, ne misero una anche al muso di Barone, e corsero via, spargendosi in tutte le case del paese. Era ormai sera, e quella ventina di spettri entravano gridando nelle stanze appena illuminate dai fuochi rossi dei camini, e dai lumini a olio ondeggianti. Le donne fuggivano atterrite: perché qui ogni simbolo è reale, e quei venti ragazzi erano davvero, quella sera, un trionfo della morte.
Così, nella Lucania degli anni Trenta, il Carnevale diventa, grazie a Carlo Levi, una serissima prefigurazione dell’Halloween di oggi.
* * *
Cristo si è fermato a Eboli non è solo un’indagine antropologica o una denuncia sociale in forma di romanzo. È l’avventura di un uomo che impara a conoscere e amare una terra e i suoi abitanti (o, se vogliamo, l’avventura di un uomo buono che ci piacerebbe aver conosciuto di persona). È un ritratto della società italiana sotto il fascismo: c’è il podestà don Luigino, maestro di scuola, che costringe ad assistere ai suoi comizi i contadini non abbastanza rapidi a nascondersi in campagna, e appena può fa cantare Giovinezza o Faccetta nera ai suoi alunni; c’è donna Caterina, sorella del podestà e moglie del segretario del Fascio, che vuole usare Levi per estendere la sua influenza tra i notabili di Gagliano e distruggere la fazione rivale, guidata dal dottor Gibilisco e dalle nipoti farmaciste; c’è lo zio di donna Caterina, il vecchio dottor Milillo, incapace come il suo concorrente Gibilisco (due «medicaciucci», a cui sarebbe stato temerario affidare anche un animale), antico liberale che può permettersi atteggiamenti anticonformisti, visto che il podestà è suo nipote.
I signori erano tutti iscritti al Partito, anche quei pochi, come il dottor Milillo, che la pensavano diversamente, soltanto perché il Partito era il Governo, era lo Stato, era il Potere, ed essi si sentivano naturalmente partecipi di questo potere.
Ma i signori, che vogliono fare parte della Storia e del Potere, passano in secondo piano, con i loro intrighi da commedia provinciale, davanti alla forza oscura del mondo contadino, dove non solo non è arrivato Cristo ma nemmeno «il tempo, né l’anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia».
Cristo si è fermato a Eboli è la realizzazione di un profondo bisogno avvertito dal suo autore: «scrivere una storia di questa Italia, se è possibile scrivere una storia di quello che non si svolge nel tempo: la sola storia di quello che è eterno e immutabile, una mitologia». È l’eternità di questa mitologia che resta scolpita nella nostra mente, e il libro ci appare ancora oggi come il risultato meraviglioso e imprevedibile di una serie di contraddizioni. Levi è stato arrestato e spedito al confino in un luogo sperduto, lontanissimo da casa, e solo così scopre un mondo che altrimenti gli sarebbe stato precluso; dovrebbe essere (ed è) un perseguitato politico, ma stringe rapporti fertili con la gente del luogo, e l’isolamento diventa un’occasione per leggere, dipingere, riflettere; è circondato da una miseria senza speranza, che tuttavia nasconde un’irresistibile vitalità.
È la contraddizione impersonata da Matera: quando Levi finalmente la vede, capisce benissimo quanto fosse giustificato l’orrore provato dalla sorella; eppure l’orrore si accompagna «alla meraviglia per quella tragica bellezza». Soprattutto, questa contraddizione vitale si manifesta, verso la fine, in un’illuminazione che potremmo considerare il fulcro segreto del libro.

Levi è stato chiamato al capezzale di un malato molto grave, in un luogo sperduto, a tre ore dal paese. Non può partire, però, perché la questura di Matera gli ha imposto (forse per invidie locali, forse perché sta diventando troppo popolare fra i contadini) il divieto di esercitare la professione medica. Alla fine, però, di fronte alla gravità del caso, il podestà e il brigadiere dei carabinieri gli concedono il permesso di andare. Ma quando Levi arriva alla masseria, il malato ormai è moribondo.
La morte era nella casa: amavo quei contadini, sentivo il dolore e l’umiliazione della mia impotenza. Perché allora una così grande pace scendeva in me? Mi pareva di essere staccato da ogni cosa, da ogni luogo, remotissimo da ogni determinazione, perduto fuori del tempo, in un infinito altrove. Mi sentivo celato, ignoto agli uomini, nascosto come un germoglio sotto la scorza dell’albero: tendevo l’orecchio alla notte e mi pareva di essere entrato, d’un tratto, nel cuore stesso del mondo. Una felicità immensa, non mai provata, era in me, e mi riempiva intero, e il senso fluente di una infinita pienezza.
Una «felicità immensa», una «infinita pienezza» che nascono, irresistibilmente, a stretto contatto con la morte; in fondo, qualcosa di molto simile si impadronisce di noi mentre leggiamo oggi Cristo si è fermato a Eboli: sprofondiamo nella desolazione, e ci invade una misteriosa felicità.
Carlo Levi (Torino, 1902 – Roma, 1975), cresciuto nella Torino antifascista di Piero Gobetti, amico dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, laureato in medicina, si è avvicinato alla pittura frequentando lo studio di Felice Casorati. Il suo capolavoro, Cristo si è fermato a Eboli, è uscito nel 1945. Tra gli altri suoi libri, L’orologio (1950) e Le parole sono pietre (1955). Il Museo nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata, che ha sede nel Palazzo Lanfranchi, a Matera, conserva molti suoi dipinti.
La facciata di Palazzo Lanfranchi. In primo piano la Goccia dello scultore italo-giapponese Kengiro Azuma.
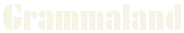



Lurkerella
Grazie per questa bellissima recensione. Anch’io ho sempre evitato questo libro, per i tuoi stessi motivi – adesso non vedo l’ora di leggerlo
francesco m.
uno dei libri più belli che abbia letto, ma già da vecchio, prima avevo gli stessi pregiudizi. f.
Massimo Birattari
Quindi non è successo solo a me…
francesco m.
Massimo, mi piacerebbe leggere un sua recensione su un caso, per me, simile: Fontamara di Silone; anch’io, come lei dice, la credevo una storia noiosa di contadini tristi, è invece un racconto anche divertente, dove mi ha colpito l’alternarsi dell'”io narrante” fra madre, padre e figlio, che trascurano protagonismo e vicende intime. f.
Franco Bellino
Grazie, Massimo. Nonostante 11 traslochi ho il libro e so dov’è. Ricordo di averlo letto e annotato, come faccio sempre. Ma questa tua recensione mi spinge a riprenderlo in mano : so che per me sarà nuovo e ancora più bello di allora. Anche perchè il rimbambimento senile mi offre il vantaggio di vivere come nuovi piacere già vissuti.