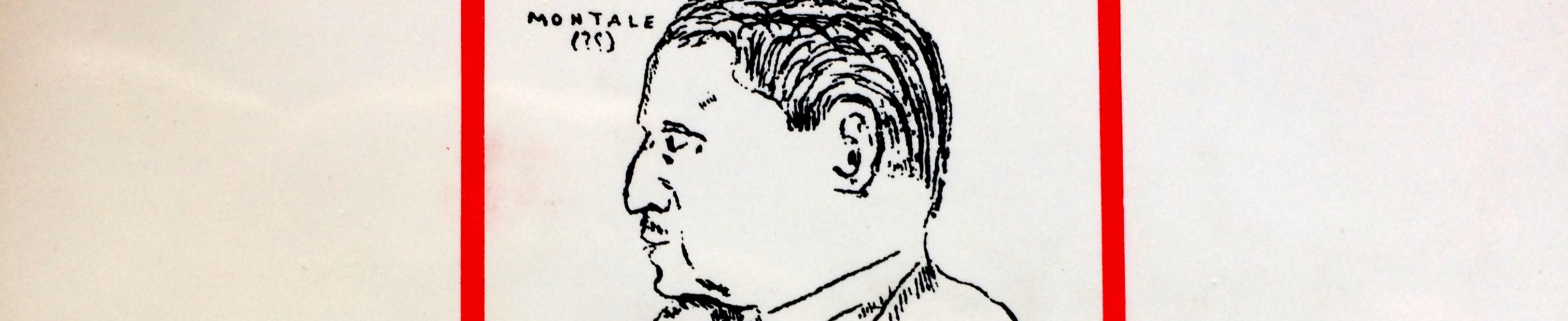
Montale e l’oscurità dei poeti
Dedicato ai maturandi (ma potete leggere questo brano anche se non dovete fare l’esame): un pezzo per capire come funziona la testa di un poeta, e come si legge (e si ama) la poesia.
Il mio libro È più facile scrivere bene che scrivere male è un corso di scrittura (non creativa) costruito attorno ad alcune parole chiave, che danno il titolo agli otto capitoli: semplicità, chiarezza, precisione, leggerezza, ironia, eleganza, espressività, consapevolezza. Ogni capitolo (tranne l’ultimo) finisce con la rubrica L’altra campana, che mostra il rovesciamento (consapevole e “necessario”) della parola-principio ispiratore da parte di uno scrittore. L’“altra campana” della chiarezza è l’oscurità (dei poeti del Novecento).
Leggete questa poesia di Eugenio Montale (1896-1981), il più grande poeta italiano del Novecento:
La speranza di pure rivederti
m’abbandonava;
e mi chiesi se questo che mi chiude
ogni senso di te, schermo d’immagini,
ha i segni della morte o dal passato
è in esso, ma distorto e fatto labile,
un tuo barbaglio:
(a Modena, tra i portici,
un servo gallonato trascinava
due sciacalli al guinzaglio).
(Eugenio Montale, Le occasioni [1939], in Tutte le poesie, Mondadori 1984)
Questa poesia non è “chiara”: o meglio, sono chiari i primi due versi, e l’immagine – una pura descrizione – negli ultimi tre; è, a prima vista, “oscuro” il corpo centrale della poesia, e il suo senso complessivo. Ma leggete adesso il passo in cui Montale, raccontando la nascita di questa poesia, tocca il “problema dell’oscurità o dell’apparente oscurità di certa arte d’oggi”. (È una narrazione in terza persona, in cui Montale è Mirco e la donna amata, il tu della poesia, è Clizia; e la situazione è quella “d’ogni poeta lirico che viva assediato dall’assenza-presenza della donna lontana”.)
Un pomeriggio d’estate Mirco si trovava a Modena e passeggiava sotto i portici. Angosciato com’era e sempre assorto nel suo ‘pensiero dominante’, stupiva che la vita gli presentasse come dipinte o riflesse su uno schermo tante distrazioni. Era un giorno troppo gaio per un uomo non gaio. Ed ecco apparire a Mirco un vecchio in divisa gallonata che trascinava con una catenella due riluttanti cuccioli color sciampagna, due cagnuoli che a una prima occhiata non parevano né lupetti né bassotti né volpini. Mirco si avvicinò al vecchio e gli chiese: “Che cani sono questi?”. E il vecchio, secco e orgoglioso: “Non sono cani, sono siacalli”. (Così pronunciò da buon settentrionale incolto; e scantonò poi con la sua pariglia). Clizia amava gli animali buffi. Come si sarebbe divertita a vederli! pensò Mirco. E da quel giorno non lesse il nome di Modena senza associare quella città all’idea di Clizia e dei due sciacalli. Strana, persistente idea. Che le due bestiole fossero inviate da lei, quasi per emanazione? […] O forse erano solo un’allucinazione, i segni premonitori della sua decadenza, della sua fine?
Fatti consimili si ripeterono spesso […]. E sempre sul vivo della piaga scendeva il lenimento di un balsamo. Una sera Mirco si trovò alcuni versi in testa, prese una matita e un biglietto del tranvai (l’unica carta che avesse nel taschino) e scrisse queste righe […].
Qui Montale riporta i versi della poesia, spiegando che gli ultimi tre erano stati aggiunti perché “occorreva un esempio che fosse anche una conclusione”, dove “la parentesi voleva isolare l’esempio e suggerire un tono di voce diverso, lo stupore di un ricordo intimo e lontano”. Racconta poi che quando la poesia fu pubblicata, i critici, confusi, chiesero spiegazioni: “E che c’entrava Modena? Perché Modena e non Parma o Voghera? E l’uomo degli sciacalli? Era un inserviente? Un uomo-pubblicità?” E qui, osserva Montale, la critica si comporta come il visitatore di una mostra che, di fronte a una natura morta di funghi, si domandi: “Quanto costano al chilo questi funghi? Sono stati raccolti dal pittore o comprati al mercato?”
L’oscurità dei classici […] è stata in parte diradata dai commenti di intere generazioni di studiosi: e non dubito che quei grandi sarebbero stupefatti dalle spiegazioni di certi loro ermeneuti. Anche l’oscurità di certi moderni finirà per cedere, se domani esisterà ancora una critica. Allora dal buio si passerà alla luce, a troppa luce: quella che i così detti commenti estetici gettano sul mistero della poesia. Tra il non capir nulla e il capir troppo c’è una via di mezzo, un juste milieu che i poeti, d’istinto, rispettano più dei loro critici; ma al di qua o al di là di questo margine non c’è salvezza né per la poesia né per la critica. C’è solo una landa troppo oscura o troppo chiara dove due poveri sciacalli non possono vivere o non possono avventurarsi senza essere braccati, catturati e rinchiusi tra le sbarre di uno Zoo.
(Eugenio Montale, Due sciacalli al guinzaglio, “Corriere della Sera”, 16.2.1950)
Secondo me, questo articolo di Montale (che nelle parti che ho dovuto tagliare parlava anche di un’altra poesia, Lontano, ero con te quando tuo padre…) è una delle migliori introduzioni possibili alla comprensione della lirica contemporanea. È una riflessione sul giusto grado di oscurità che serve a preservare il “mistero della poesia”. Quindi sostiene che ci sono territori che possono legittimamente sottrarsi all’imperativo della chiarezza (ma avrete notato che questa difesa dell’oscurità è stata scritta in una lingua cristallina).
Questo brano proviene dal mio libro È più facile scrivere bene che scrivere male, Ponte alle Grazie 2011, pp. 59-61. L’articolo di Montale è stato pubblicato in volume in Sulla poesia, a cura di Giorgio Zampa, Mondadori 1976, poi nelle note dell’edizione critica, L’opera in versi, a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Einaudi 1980, e ancora in Mottetti, a cura di Dante Isella, Adelphi 1988.
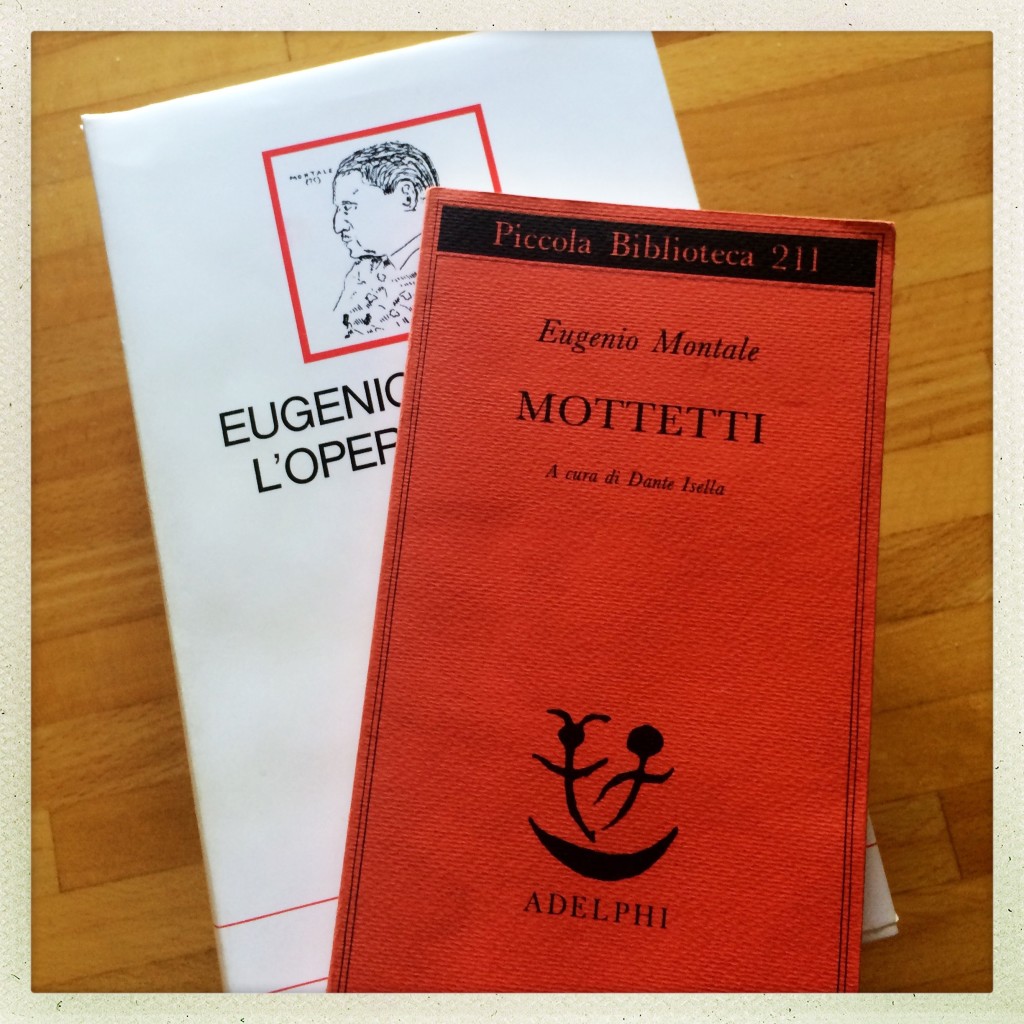
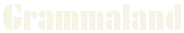


Kukuviza
Questo post è molto interessante così come le zone di penombra della poesia (e arte in genere).
Tuttavia, se uno leggesse quella poesia senza leggere il bel brano di spiegazione, cosa capirebbe da quei tre versi? Non sono troppo criptici? Invece dopo aver letto la spiegazione, tutto acquista un senso e si vede la bellezza di quei versi.
Massimo Birattari
Questo è davvero un punto cruciale. Anche l’allusione maliziosa di Montale alle interpretazioni che i critici danno ai versi dei classici in fondo ruota attorno a questo tema. È appunto il problema della poesia “oscura” (pensiamo a Dante o a Eliot). Potremmo dire che la poesia è (anche) ciò che va al di là della spiegazione, che la sua ambiguità è una ricchezza, che anche il fraintendimento può non essere un male, che conta soprattutto la forza evocativa dei suoni o delle immagini. Comunque quel problema resta. In questo caso, però, per me il problema non sono gli ultimi tre versi, ma la “strofa” intermedia, o meglio il legame tra quei cinque versi e la situazione/immagine finale. E forse questo testo di Montale (potrei anche fare un altro post sull’altra metà dell’articolo, con la poesia “Lontano, ero con te quando tuo padre…”) può diventare una guida alla lettura di altre sue poesie (per le quali converrà anche consultare i commenti di molti bravi critici).
Kukuviza
Il collegamento non è forse spiegato dal brano di Montale?
Quello che io ho capito è che, in assenza della persona amata, l’amante trova con essa dei collegamenti che non esistono nella realtà, nemmeno nel passato, ma solo a livello suo sentimentale e che gli fanno comunque avere quegli scintillii e quei riflessi. L’immagine di Modena coi suoi sciacalli costuisce quel barbaglio.
Massimo Birattari
Certo. Intendevo dire che i versi centrali e il collegamento con i tre finali sono “oscuri” se uno non ha letto l’autocommento di Montale.
Ho un aneddoto personale che ho ricordato nella risposta a un commento su Facebook. Su questa poesia sono stato interrogato da Contini in persona (!). Era l’ottobre 1980, lui aveva finito l’edizione critica di Montale, che però sarebbe stata pubblicata a dicembre. Io non avevo letto “Sulla poesia”, quindi ho brancolato nel buio, bofonchiando qualcosa di impressionistico. Lui, impietosito, è passato a una poesia di “Satura” MOLTO più immediata (Dopo lunghe ricerche | ti trovai in un bar dell’Avenida | da Liberdade…), spiegandomi che proprio per l’edizione critica aveva fatto correggere a Montale l’originale Libertade (perché in portoghese si scrive con due D). Quando, mesi dopo, ho scoperto l’autocommento di Montale a “La speranza di pure rivederti”, mi sono detto: accidenti, se l’avessi letto prima avrei fatto un figurone. (Comunque l’esame era andato bene.)
Kukuviza
Ok, chiarito l’equivoco. Quando avevo scritto che quei tre versi erano criptici, in effetti intendevo soprattutto criptici rispetto al contesto.
Viene chiesto dai professori di fare delle analisi personali alle poesie? E in generale, dopo tutte le pagine di critica, è ancora possibile trovare in una poesia qualcosa di “nuovo”? (chiedo da totale profana)
Massimo Birattari
Non sono un insegnante e conosco il mondo della scuola soprattutto attraverso alcuni amici insegnanti. Direi che un buon modo per capire quello che si chiede ai ragazzi è guardare le domande dell’analisi del testo alla maturità (quest’anno proprio su una poesia, di Caproni). Direi che si invitano i ragazzi ad analizzare il testo con gli strumenti della critica.
Se, per quanto riguarda ragazzi più piccoli, vuole vedere un’esperienza tutto sommato unica (e molto anni Settanta…), legga qui (è una delle cose migliori che troverà in questo sito, glielo dico subito): https://www.grammaland.it/liuba-ovvero-la-poesia-salvata-dai-ragazzini/
Kukuviza
Molto bello l’articolo. Ma anche il resto del blog lo è
Paola Boetti
Il suo blog così come i suoi libri sono utilissimi. Anche il suo ultimo libro sul “non fare i compiti” è veramente bello. Complimenti per le sue idee.
Massimo Birattari
Grazie!
Stefania Botturi
Questo blog è splendido, divertente, mi fa ridere, ispira, fa sorgere domande. Istruisce senza annoiare. Bello bello. Grazie!
Massimo Birattari
Grazie. Purtroppo l’autore è un po’ latitante, ultimamente.
Stefania Botturi
Ci sarà certamente un motivo valido.