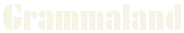Bambini in guerra, 100 anni fa
Nel centenario dell’attacco austriaco e tedesco a Caporetto, l’avventura di un ragazzo di tredici anni in fuga – da solo – dalla zona di guerra.
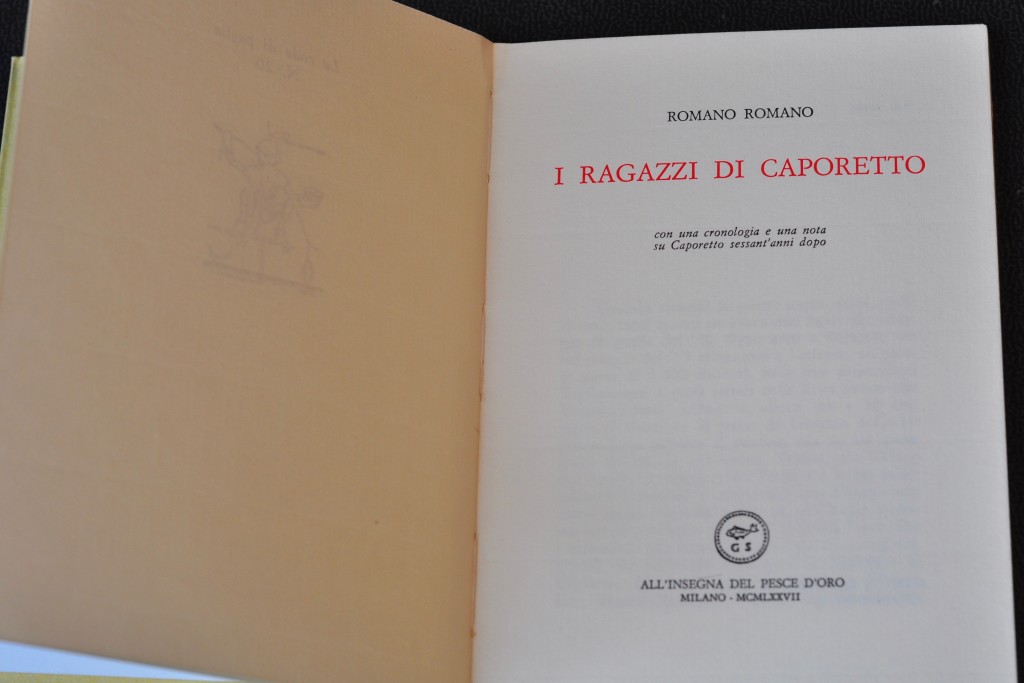
Il frontespizio del libro I ragazzi di Caporetto, in cui Romano Romano (padre dello storico e giornalista Sergio Romano) racconta le sue esperienze durante la Prima guerra mondiale.
Romano è un ragazzo del 1904, vive in Friuli e dunque dal 24 maggio 1915, quando l’Italia entra nella Prima guerra mondiale, si trova vicinissimo al fronte. A Udine, dove va a scuola, vede spesso il comandante in capo Luigi Cadorna “che passeggiava da solo per i viali, seguito da due carabinieri”; come boy scout fa “il turno di soccorso alla stazione ferroviaria dove i treni carichi di truppe e i treni-ospedale passavano in continuazione nei due sensi”; e assiste anche a un combattimento dell’asso dell’aeronautica italiana, Francesco Baracca:
un giorno mi chiamarono in terrazza, di corsa, per vedere uno scontro fra due aerei nel cielo della città. Cadde l’aereo austriaco e la gente intorno a me diceva che l’aveva abbattuto Baracca.
Nel 1917, Romano trascorre l’estate con la famiglia a Latisana (ma il padre è stato richiamato ed è sotto le armi). Le città e i paesi vicini alla linea del fronte sperimentano in anteprima quello che diventerà l’incubo delle popolazioni civili durante la Seconda guerra mondiale: i bombardamenti aerei.
A Latisana, la guerra, psicologicamente, era più vicina che mai. Dall’argine del Tagliamento vedevamo le artiglierie e nelle notti di luna scendevamo in rifugio al suono delle campane mentre gli aerei austriaci e tedeschi cominciavano a bombardare. Fu colpito l’autoparco, crollò qualche casa, vi furono morti. Noi ragazzi riuscivamo a dormire anche nel rifugio che era una cantina-trincea costruita secondo le istruzioni di mio padre.
Proprio perché la situazione a Latisana è sempre più difficile, Romano viene rimandato in anticipo nel collegio di Vittorio Veneto dove, ai primi di novembre, sarebbe cominciato il nuovo anno scolastico. Ma il 24 ottobre austriaci e tedeschi lanciano l’offensiva: sfondano le linee italiane a Caporetto, passano l’Isonzo, stanno per prendere Udine e superare il Tagliamento. L’esercito italiano si ritira in maniera disordinata, i comandi hanno deciso di organizzare la resistenza dietro il Piave, centinaia di migliaia di civili scappano davanti all’avanzata austriaca. Anche il collegio deve essere evacuato: il comando dichiara Vittorio Veneto zona di guerra e ordina l’arruolamento di tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni. Anche i professori della scuola, dunque: nessuno potrà più occuparsi dei ragazzi, una decina, che non possono nemmeno tornare a casa, perché i loro paesi si trovano in una zona di guerra che sta per essere occupata dai nemici. Nelle loro condizioni ci sono anche dieci ragazze. Il direttore firma due lettere per un collegio di Bologna, le consegna ai due alunni più grandi, Romano e una ragazza anche lei tredicenne di Casarsa, e quelle due lettere sono il lasciapassare grazie al quale i venti piccoli profughi dovranno raggiungere da soli in treno Bologna, distante più di 200 chilometri. Oltre alle lettere, i ragazzi ricevono anche “qualche sacco di mele, un sacco di mortadelle, qualche pagnotta”.

L’immagine sulla copertina del libro riproduce un manifesto per la sottoscrizione del Prestito nazionale dopo Caporetto. I tre brutti ceffi sono soldati austriaci invasori che mettono le mani addosso a una donna italiana.
Immaginate dieci ragazzi e dieci ragazze che probabilmente non hanno mai preso un treno da soli, in viaggio verso una città sconosciuta tra vagoni e stazioni dove regna il caos di un attacco nemico, con gli austrotedeschi che hanno già sfondato e minacciano di puntare su Venezia, una grossa parte dell’esercito italiano in fuga, gente che scappa per paura degli invasori, soldati in arrivo dalle retrovie per prendere il posto dei prigionieri e dei fuggiaschi, movimenti di truppe da sistemare dietro il Piave…
Per percorrere i 70 chilometri da Vittorio Veneto a Mestre, passando da Conegliano, ci vogliono tre o quattro giorni. A Mestre, per caso, Romano incontra suo padre, che sta per prendere il comando di una stazione vicina e riesce a sistemare i ragazzi sul vagone di terza classe di un treno diretto a Bologna.
A Padova le ragazze restano sul vagone, mentre i ragazzi devono salire sul carro bestiame di un treno più lento. Vicino a Ferrara, Romano e un amico si offrono di andare a cercare del cognac per una signora di Udine che si sente male; se lo procurano ma, quando tornano, vedono che il treno sta ripartendo.
Il pensiero di esser soli e di abbandonare i nostri compagni, tutti più giovani di noi, ci mise addosso una tale paura e una tale agitazione che ci demmo a correre come lepri. Per fortuna il treno andava piano e i compagni di viaggio erano pronti a sollevarci di peso. Il cognac finì in gran parte lungo la ferrovia, ma un po’ ne rimase per la signora di Udine che lo bevve, stette meglio e non la smetteva di ringraziarci.
Dopo Ferrara, i ragazzi (che naturalmente non disponevano di GPS né di Google Maps ma dovevano aver studiato la geografia) si accorgono che qualcosa non va.
Chiesi informazioni durante una fermata e la persona a cui m’ero rivolto rispose che eravamo sulla linea Ferrara-Rimini. “Ma noi – dissi – dobbiamo andare a Bologna.” “Questo – ribatté l’altro – va nelle Puglie.”
Così, per non finire a Bari, i ragazzi scendono alla stazione di Rimini per aspettare lungo la massicciata un treno che vada nella direzione opposta. Nel giro di un’ora salgono su un treno per Bologna, e i passeggeri si meravigliano alla vista di dieci ragazzi vestiti da alpini (era l’uniforme del collegio) in fuga da soli dalle terre conquistate dagli austriaci.
Allora furono tutti molto gentili e chi ci offriva una cosa, chi l’altra. Finché arrivò il controllore che ci chiese molto fermamente i biglietti. Io ricominciai a spiegare che eravamo profughi e che venivamo da Vittorio Veneto, e gli mostrai anche la lettera per il collegio di Bologna. Ma lui rispose che non era autorizzato. “I profughi, disse, viaggiano su treni speciali e questo è un treno ordinario. Bisogna scendere alla prossima stazione.”
Per fortuna tutti i viaggiatori presero le nostre difese e si misero a discutere con il controllore sostenendo che questo era un caso eccezionale e che non poteva farci scendere dal treno in quel modo. Lo dovette capire anche lui perché dopo avere difeso il regolamento mi guardò in faccia e mi disse: “Va bene, vieni a Bologna”.
Con grande fatica Romano e i suoi compagni raggiungono il collegio delle salesiane dove già erano state accolte le ragazze. Siccome però è un collegio femminile, i ragazzi si fermano solo pochi giorni, in regime di segregazione (possono uscire dalle camerate solo quando le loro compagne vanno al refettorio a mangiare); poi vengono mandati al Collegio nazionale di Torino.
A un mese e mezzo dalla partenza da Vittorio Veneto, “dissipatisi i fumi dell’avventura”, Romano si rende conto di non avere notizie né del padre né della madre né degli altri membri della sua famiglia (d’altra parte, non c’erano i cellulari). Si ricorda di avere l’indirizzo di una zia, sposata a Milano, che il padre gli aveva dato a Mestre. Così le scrive, e la zia lo invita a trasferirsi da lei. Solo a gennaio ritrova il padre, e solo a febbraio, grazie ad alcuni annunci sui giornali, anche la madre, che con il resto della famiglia aveva trovato ospitalità a Firenze.
Dopo l’estate, Romano si trasferisce a Firenze con la madre e i nonni. Il pomeriggio del 4 novembre 1918, è a teatro quando all’improvviso cade il sipario e l’attore protagonista, il celebre Ermete Zacconi, ancora truccato da conte di Cavour, esce agitando un foglietto e legge il bollettino della vittoria firmato dal generale Diaz (quello che finisce con la frase: “I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”). Il giorno dopo, il ragazzo arriva a Milano con la madre, ma subito si ammala: è stato contagiato dalla spagnola, la terribile influenza che nel giro di sei mesi ucciderà 50 milioni di persone in tutto il mondo.
Quando uscii dal letto un mese dopo mi dissero che ero stato gravissimo e che avevano temuto per la mia vita.
Finalmente, dopo aver trascorso la convalescenza in un collegio di Varese e dopo che i genitori sono tornati a Latisana per rendere di nuovo abitabile la loro casa, di cui erano rimasti solo i muri (“le truppe in partenza e quelle in arrivo – italiani? austriaci? tedeschi? – l’avevano completamente svuotata”), nel luglio 1919, ultimo della famiglia, Romano torna a casa.
Pochi giorni dopo compii i 15 anni ed ebbi in dono da mia madre un libro di educazione sessuale intitolato Come si nasce. Da mio padre ebbi le chiavi di casa.
Romano Romano (padre dello storico e giornalista Sergio Romano) ha raccontato le sue esperienze durante la Prima guerra mondiale nel libro I ragazzi di Caporetto, a cura di Vanni Scheiwiller e Sergio Romano, All’insegna del pesce d’oro, 1977, pp. 64. Il libro – stampato il 24 ottobre 1977, cioè nel sessantesimo anniversario dell’attacco austrotedesco a Caporetto – offre anche una cronologia, una postfazione di Sergio Romano e quattro fotografie fuori testo.