Robinson all’inferno
Leggere Se questo è un uomo di Primo Levi (con scandaloso ritardo, e continuando a rileggere).
Grazie alla mia ormai lunga esperienza delle cose del campo, ero riuscito a portare con me le mie cose personali: una cintura di fili elettrici intrecciati; il cucchiaio-coltello; un ago con tre gugliate; cinque bottoni; e infine, diciotto pietrine per acciarino che avevo rubato in Laboratorio. Da ognuna di queste, assottigliandola pazientemente col coltello, si potevano ricavare tre pietrine più piccole, del calibro adatto a un normale accendisigaro. Erano state valutate sei o sette razioni di pane.
È l’11 gennaio 1945: Primo Levi, internato a Monowitz-Auschwitz da quasi un anno (un tempo lunghissimo rispetto alla sopravvivenza media), si ammala di scarlattina e viene ricoverato nell’infermeria del campo. A prima vista, gli oggetti che, nonostante i divieti, riesce a portare con sé non sembrerebbero così importanti. Ma Levi è esperto, ha imparato presto che nel campo la sua sopravvivenza dipenderà dalle cose che riesce a procurarsi (e a impiegare) con la sua ingegnosità: se le pietrine per acciarino valgono sei o sette razioni di pane, significa che per un po’ di tempo non morirà di fame.
Il suo modesto tesoro è come la cassetta da falegname che Robinson Crusoe, scampato al naufragio e ormai in salvo sull’isola deserta, cerca a lungo sulla nave incagliata davanti alla spiaggia; e quando la trova, la considera un bottino utilissimo, “molto più prezioso, in simili circostanze, di una nave carica d’oro”. Infatti quegli attrezzi, e quelli che produrrà grazie a essi, gli consentiranno di procurarsi il cibo con la caccia e l’agricoltura, di costruirsi una casa, di sopravvivere da solo nella natura selvaggia.
Però il giovane Levi (ha ventiquattro anni quando arriva nel Lager) è un Robinson precipitato all’inferno, che contrariamente all’eroe di Defoe non ha nessuna speranza di tornare a casa: perfino pochi giorni prima della liberazione, con i tedeschi ormai fuggiti, si rifiuterà di pensare alla salvezza.
L’idea di Levi ad Auschwitz come un Robinson all’inferno era venuta, ben prima che a me, al grande scrittore americano Philip Roth, che l’aveva sottoposta allo stesso Levi in un’intervista del 1986. Roth si riferiva all’ultimo capitolo di Se questo è un uomo, “Storia di dieci giorni”: i dieci memorabili giorni che vanno dal 18 gennaio 1945, in cui i tedeschi abbandonano il Lager portando con sé i circa ventimila superstiti sani (verranno quasi tutti uccisi durante la marcia di allontanamento), al 27 gennaio, quando ad Auschwitz arrivano i russi.
Sono dieci giorni “fuori del mondo e del tempo”: il campo si svuota nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, restano solo, del tutto abbandonati a sé stessi, gli ottocento ricoverati dell’infermeria, molti dei quali troppo malati per sopravvivere a lungo. Sulla sua isola tropicale, Robinson elenca, tra gli aspetti negativi della sua condizione, il fatto di essere separato dal consorzio civile e di non avere vestiti, ma subito nota che il luogo in cui si trova è tutt’altro che sterile e fa talmente caldo che i vestiti sarebbero inutili. Anche coloro che sono rimasti ad Auschwitz hanno vestiti leggeri, una camicia o nemmeno quella, ma in Polonia è pieno inverno, ci sono venti gradi sotto zero, e le cucine e il riscaldamento centrale hanno smesso di funzionare.
Nella cameretta di Levi, i meno gravi sono i malati di scarlattina, lui e due francesi arrivati da poche settimane, il più anziano Arthur, contadino, e il maestro di scuola Charles, trentadue anni. Sono loro, dunque, gli unici che possono uscire, nella nebbia, avvolti nelle coperte, in cerca di cibo, legna e soprattutto di una stufa da impiantare nella baracca. Recuperano due sacchi di patate, legna e brace nelle baracche colpite nella notte da un bombardamento russo, e una pesante stufa di ghisa che Levi, stravolto per la fatica e la malattia, riesce a trasportare su una carriola fino al dormitorio. Nonostante la stanchezza, nonostante il gelo che incolla la pelle al metallo, Levi e i due francesi riescono ad avviare la stufa e a far bollire le patate, e qui accade qualcosa di straordinario: un polacco malato di tifo propone che ciascuno doni una fetta di pane della propria scorta ai tre che hanno lavorato per il bene di tutti.
Soltanto un giorno prima un simile avvenimento non sarebbe stato concepibile. La legge del Lager diceva: “mangia il tuo pane, e, se puoi, quello del tuo vicino”, e non lasciava posto per la gratitudine. Voleva ben dire che il Lager era morto.
Fu quello il primo gesto umano che avvenne fra noi. Credo che si potrebbe fissare a quel momento l’inizio del processo per cui, noi che non siamo morti, da Häftlinge siamo lentamente ridiventati uomini.
Quando, nell’intervista del 1986, Philip Roth gli propone l’analogia con Robinson Crusoe, Levi annuisce convinto:
Hai colpito nel segno. È proprio vero che, in quei memorabili dieci giorni del gennaio 1945, io mi sono sentito come Robinson Crusoe, ma con una importante differenza. Robinson si era messo al lavoro per la sua individuale sopravvivenza; io ed i miei due compagni francesi eravamo consci, e felici, di lavorare finalmente per uno scopo giusto e umano, quello di salvare le vite dei nostri compagni ammalati.
Il “primo gesto umano”, uno “scopo giusto e umano”: il memoriale di Levi si intitola Se questo è un uomo proprio perché vuole rendere testimonianza, attraverso il puro resoconto degli eventi, del fatto mostruoso e terribile che ad Auschwitz non esiste più l’umanità.
I personaggi di queste pagine non sono uomini. La loro umanità è sepolta, o essi stessi l’hanno sepolta, sotto l’offesa subita o inflitta altrui.
Questo vale dunque sia per le SS sia per gli Häftlinge, i reclusi. Ed è proprio perché, con la fine del Lager, ritorna l’umanità – e con essa la speranza di salvezza e l’idea stessa di futuro, altri concetti del tutto assenti tra campi di lavoro e camere a gas – che le pagine finali del libro sono così entusiasmanti e, di fatto, avventurose come quelle di Robinson Crusoe. (Sempre nell’intervista di Roth, Levi accenna all’aspetto “avventuroso” di Se questo è un uomo e soprattutto del suo seguito, La tregua, il romanzo picaresco in cui racconta il complicato ritorno da Auschwitz a Torino passando dalla Russia: “La famiglia, la casa e la fabbrica sono cose buone in sé, ma mi hanno privato di qualcosa di cui ancora oggi sento la mancanza, cioè dell’avventura. Il mio destino ha voluto che io trovassi avventura proprio in mezzo al disordine dell’Europa devastata dalla guerra”.)
L’alba del 20 gennaio, Levi è troppo debole per affrontare il gelo e procurarsi la brace per accendere la stufa. Si ricorda però delle pietrine da acciarino, uno dei suoi possessi più preziosi. Imbeve di spirito un foglietto di carta, gratta un po’ di polvere di una pietrina sul foglietto e poi si mette a raschiare più forte col coltello: “dopo qualche scintilla il mucchietto deflagrò, e dalla carta si levò la fiammella pallida dell’alcool”. Dopo aver acceso la stufa, Levi e Charles escono in cerca di cibo, e recuperano un pacco di sale, un bidone con una cinquantina di litri di acqua ghiacciata e cinquanta chili di cavoli e rape così induriti dal gelo che devono essere scalpellati via con un piccone. Poi, nel pomeriggio, Levi setaccia l’ambulatorio; è già stato saccheggiato, ma qualcosa era sfuggito ai predecessori: una batteria di camion, carica. “La sera la nostra camera aveva la luce.”
Il 22 Levi e Charles entrano in un luogo ricco di tesori preziosi come la stiva della nave di Robinson, e molto più pericoloso di un relitto che sta per affondare: gli alloggi abbandonati in tutta fretta dalle SS. Trovano “una bottiglia di vodka, medicinali vari, giornali e riviste e quattro ottime coperte imbottite, una delle quali è oggi nella mia casa di Torino”.
Il 23, qualcuno taglia il filo spinato: “per la prima volta dal giorno del mio arresto, mi trovavo libero, senza custodi armati, senza reticolati fra me e la mia casa”; e quattrocento metri oltre il recinto, la scoperta di un giacimento di patate coperte di paglia garantisce che nessuno morirà più di fame.
È il trionfo della vita che ritorna; ma è una vita circondata dalla morte che non ha in nulla allentato la sua presa. Mezz’ora dopo la scorreria negli alloggi dei tedeschi, alcune SS disperse scoprono diciotto francesi che si erano stabiliti nel loro refettorio, e li uccidono uno a uno con un colpo alla nuca, abbandonando i cadaveri nella neve. Nelle baracche, anche in quella calda e illuminata di Levi, Charles e Arthur, nessuno guarisce, anzi i malati continuano a morire, nelle cuccette, tra gli escrementi dei dissenterici, perfino nelle fosse piene di patate.
E accanto alla morte è sempre presente la minaccia della “bestializzazione”: “È uomo chi uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia; non è uomo chi, perso ogni ritegno, divide il letto con un cadavere”. E qui Levi scrive una delle frasi che definiscono la sua esperienza e il suo libro:
Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta: ecco perché è non-umana l’esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l’uomo è stato una cosa agli occhi dell’uomo.
È una cosa il chimico ungherese sulla cinquantina che agonizza per una notte e altri due giorni ripetendo ossessivamente “Jawohl”, per poi precipitare dalla cuccetta sul pavimento, “infame tumulto di membra stecchite, la cosa Sómogyi”.
* * *
Mi vergogno a confessarlo, ma ho letto per intero, dall’inizio alla fine, Se questo è un uomo solo pochi anni fa, quando avevo già superato i cinquant’anni. Certo, ne conoscevo alcune pagine fin dalle medie, avevo letto e amato altri libri di Primo Levi, ma era come se considerassi “non necessaria” la lettura di Se questo è un uomo: avevo letto molti saggi sul nazismo, sulla persecuzione degli ebrei, sullo sterminio, sapevo già tutto su Auschwitz…
Trascuravo un dettaglio: che Se questo è un uomo è il libro più importante scritto in italiano negli ultimi cent’anni (o forse, detto in altri termini, l’unico davvero indispensabile, il libro italiano di cui il mondo non potrebbe fare a meno). Lo so, queste classifiche lasciano sempre il tempo che trovano, ma questo romanzo-memoriale è davvero qualcosa di unico. Per la forza di parole che colpiscono tutte nel segno: Levi chimico di professione, Levi testimone dall’inferno è uno scrittore di straordinaria potenza, come dimostra ogni singola pagina del libro e dimostreranno i tanti libri che scriverà in seguito.
Se questo è un uomo – che si apre il 13 dicembre 1943, quando Levi viene catturato dalla Milizia fascista e mandato come ebreo nel campo di internamento di Fossoli, vicino a Modena, e si conclude con l’arrivo dei russi ad Auschwitz, il 27 gennaio 1945 – è uno dei libri più pessimisti che siano mai stati scritti: non solo per la rappresentazione dell’ingiustizia, della barbarie, della disumanità, ma soprattutto per la visione lucida e spietata del male, un male assoluto perché contamina anche le vittime. Basti pensare alla scena terribile del vecchio Kuhn, un internato che, nel silenzio della baracca, “prega, ad alta voce, col berretto in testa e dondolando il busto con violenza”, ringraziando Dio perché, almeno quella volta, non è stato selezionato per finire nelle camere a gas.
Kuhn è un insensato. Non vede, nella cuccetta accanto, Beppo il greco che ha vent’anni, e dopodomani andrà in gas, e lo sa, e se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più niente? Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta? Non capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell’uomo di fare, potrà risanare mai più?
Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn.
Eppure, leggere Se questo è un uomo è in sé un’esperienza vitale – è una delle letture che di fatto cambiano la vita – prima di tutto grazie a una dote dell’autore: la straordinaria intelligenza (un’intelligenza che coinvolge contemporaneamente lo sguardo, la mente, il cuore e la scrittura) che gli consente di illuminare l’essenza di Auschwitz. Spiega Levi a Roth:
Avevo un desiderio intenso di capire, ero costantemente invaso da una curiosità che ad alcuni è parsa addirittura cinica, quella del naturalista che si trova trasportato in un ambiente mostruoso ma nuovo, mostruosamente nuovo.
Il mondo mostruosamente nuovo di Auschwitz ha le sue regole, la sua grammatica – in cui il “futuro prossimo” (“quanto si mangerà oggi, se nevicherà, se ci sarà da scaricare carbone”) ha cancellato il “futuro remoto”, che semplicemente non esiste – e il suo lessico, con parole come sommersi e salvati (quelli destinati a soccombere e coloro che hanno le qualità per sopravvivere), selezione (la procedura periodica attraverso la quale i più deboli vengono tolti dal campo di lavoro e spediti “in gas”), combinazione e organizzare (il nome e il verbo che indicano tutte le attività grazie alle quali gli internati riescono a procurarsi cibo, oggetti, vantaggi).
E mentre con disincantata intelligenza presenta Auschwitz come esperimento supremo di “bestializzazione”, Levi ci regala alcuni strazianti momenti di umanità impossibili da dimenticare: le madri che preparano il cibo per il viaggio e fanno il bucato la sera prima di partire da Fossoli per Auschwitz (“Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino voi non gli dareste oggi da mangiare?”); Pikolo, il più giovane del Kommando Chimico, che mentre va con Levi a prendere il bidone da cinquanta litri della zuppa gli fa raccontare e ripetere il canto XXVI dell’Inferno, quello di Ulisse, perché si accorge che gli sta facendo del bene; Lorenzo, l’operaio civile italiano (dunque non internato) che ogni giorno per sei mesi porta a Levi un pezzo di pane e gli avanzi del suo rancio senza voler nulla in cambio, “perché era buono e semplice, e non pensava che si dovesse fare il bene per un compenso”.
In mezzo alla sterminata pianura piena di gelo e di guerra, nella cameretta buia pullulante di germi, ci sentivamo in pace con noi e col mondo. Eravamo rotti di fatica, ma ci pareva, dopo tanto tempo, di avere finalmente fatto qualcosa di utile; forse come Dio dopo il primo giorno della creazione.
Così scrive Levi alla fine della lunga giornata del 19 gennaio, quella in cui lui, Charles e Arthur decidono di lavorare per il bene di tutti. In mezzo al dilagare del male – il male provocato dagli uomini, le malattie che rendono il finale di Se questo è un uomo simile alle più celebri descrizioni delle pestilenze del passato – noi che leggiamo col cuore in gola queste pagine non possiamo che essere riconoscenti per il dono di aver incontrato un campione di umanità come Primo Levi.
Se questo è un uomo fu pubblicato nel 1947 dalla piccola casa editrice torinese De Silva. Divenne un caso mondiale solo a partire dal 1958, quando uscì presso Einaudi (che l’aveva rifiutato nel 1947). L’intervista di Philip Roth a Primo Levi, uscita sulla “New York Times Book Review” il 12 ottobre 1986, si può leggere in Primo Levi, Conversazioni e interviste (1963-1987), a cura di Marco Belpoliti, Einaudi 1997.
Il gergo speciale di Auschwitz è ovviamente comune a tutte le lingue parlate nel campo, come dimostra questa tavola tratta dal capolavoro di Art Spiegelman, Maus (il protagonista, il padre del disegnatore, è un ebreo polacco):

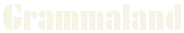


Simona Balzi
Ho letto la prima volta “Se questo è un uomo” nei primi anni del liceo e da allora l’ho letto più volte. Devo dire che è l’unico libro di cui io senta veramente il bisogno di rileggerlo, per non dimenticare e anche perché è scritto magistralmente.
Massimo Birattari
Sì, è proprio così: conosco svariate persone che non possono fare a meno di rileggerlo.